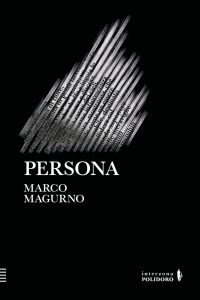Persona, Marco Magurno
(Polidoro, 2024)
Persona è un romanzo transmediale scritto da Marco Magurno, pubblicato nella collana Interzona di Polidoro. È un oggetto narrativo non identificato, un romanzo scomposto, in cui si riescono a intravedere gli elementi classici della narrazione solo attraverso la loro assenza o la loro negazione: la figura dell’eroe si dissolve in un’indeterminata “persona”, la trama continua a esistere, annegata da un emergere continuo di frammenti, invocazioni, immagini. Persona attinge da generi diversi: il romanzo, il frammento, il poema epico, il testo sacro, in una ricerca molto curata sull’uso della parola. Parola che viene ulteriormente costretta a rapportarsi con le immagini, in un doppio orizzonte linguistico e visuale. Persona è un’opera sulla transitorietà, sull’essere umano in quanto stato intermedio tra il vivere e il morire, ed è anche un tentativo di catturare il presente nel suo dissolversi: le percezioni dell’uomo e del suo vissuto nel rapporto con la tecnologia, i nuovi media, la creazione continua di immagini e di (falsi) ricordi, un eterno presente senza memoria.
Di questi e altri temi ho parlato con l’autore.
Persona è un oggetto narrativo non identificato, un “romanzo transmediale”, un susseguirsi di immagini, momenti, di frammenti. L’uso della parola, che è sempre molto esatta e essenziale, lo avvicina più alla poesia che a quello che comunemente è definito ‘romanzo’. Vorrei chiederti se e cosa rimane del romanzo nel tentativo di approccio letterario ai frammenti che compongono la vita (e la morte).
Devo dire che la definizione di “oggetto narrativo non identificato” accompagna sempre i miei lavori. Mi piace l’idea che richiama: il libro come oggetto “alieno”, una navicella spaziale in visita da altri mondi (o da altri tempi) che viola le leggi date e fa capolino nel nostro spazio-tempo iper-concettualizzato e iper-verbalizzato. Ascoltiamo il mondo: parole, parole ovunque. Ci abitano come demoni e fuoriescono dal corpo in ondate talvolta inarrestabili: crediamo di essere noi a dirle e in realtà siamo “parlati” da loro. Ma un buddha disse “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno”. Credo davvero che di ogni parola di troppo, alla fine, ci verrà chiesto conto. Di qui il mio lavoro sul testo: rarefazione, essenza, una parola che avesse il peso specifico di un piccolo buco nero. Tu la chiami “poesia”: è un altro modo per dire “salvazione”.
Ho definito Persona come un romanzo visuale e transmediale. La parola, nel libro, cede spesso il posto all’immagine e viceversa, e l’immagine crea, nella mente di chi legge e guarda, altre immagini e altre parole. Le pagine di Persona sono dei rerum vulgarium fragmenta, per citare il titolo di un’opera che sta a fondamento della nostra tradizione letteraria, delle rime sparse. Tuttavia si suppone che un “romanzo” sia anche intreccio, trama, una storia che parte e arriva. Ma cosa rimane di un intreccio, di una trama, quando la nostra vita si riduce a una sequela sfilacciata di frammenti? La vita elettronica assomiglia sempre più a una Černobyl mentale, una “zona”: non ci sono viaggi né eroi, ma qualche zona resta o illuminata o da illuminare.
Per rispondere alla tua domanda: mi piace pensare che del romanzo – quello splendido delirio, quella volontà demiurgica e sempre votata al fallimento di inscatolare il mondo e dirlo – non resti che quel che c’era all’inizio di tutto: la poesia, la parola salvata.
Sia in questa tua risposta, sia all’interno del testo, si percepisce una dualità data alla parola e all’atto del comunicare: la condanna e la salvezza; la parola che è morte e rinascita. C’è quindi ancora una fiducia nel potere della parola, e nella ricerca di (o nella consapevolezza che esista) una parola che è l’ultima parola.
Condanna e salvezza, sì. La nostra tradizione pone il logos al principio, il pensiero e la parola saldati in una forma primigenia, il verbo di Dio stesso fattosi uomo. Ci sono poi tradizioni e pratiche che vertono sul silenzio del logos, sull’azzeramento del pensiero e della lingua. Ma anche laddove si ponga una fiducia assoluta nella parola finiamo col collocare la nostra salvezza nella sua dissoluzione. Ma cos’altro abbiamo, poi, in fondo, oltre alle parole? Tra le prime azioni di Adamo ci fu quella di dare il nome alle cose per farle davvero esistere e poi suppostamente dominarle. Sotto una pietra del Golgota, che in aramaico vale per “cranio o teschio”, risiede la sua tomba: è il Calvario, “il luogo del cranio”. Che sia stata la parola, il suo peccato?
Per William Burroughs il virus più pericoloso e letale è proprio la parola.
Mi chiedo, tuttavia, come sarà l’ultima parola umana, visto che sarà inevitabile l’esistenza di una “ultima parola umana”. Me lo chiedo poeticamente, ovvio. Nessuno si troverà lì a prendere nota. O forse sì: adesso che te lo dico mi apparire l’immagine di uno scriba, incappucciato e chino, muto, che trascrive quest’ultima parola. Mi affascina, e mi inquieta, immaginarlo. Siamo l’unica specie ad aver inventato questa tecnologia, il linguaggio verbale, autoinfettandosi con questo morbo, ma per fortuna l’universo continua e continuerà a parlare in infiniti altri modi.
Nonostante Persona si componga di una successione di frammenti, nell’approcciarmici – forse per una tendenza naturale – ho riconosciuto una linearità. Un poema (ed è per questo che lo associavo alla poesia) che inizia con un’invocazione, e che ha una traiettoria ben precisa (forse così precisa da poter rinunciare agli eroi per raggiungere il bersaglio).
Sì, i frammenti finiscono sempre per riunirsi. Nella lettura, nel pensiero, per ristabilire l’ordine che li precede.
Larga parte della letteratura delle origini ci è giunta in forma di frammento, per citazioni, su pezzi di papiro, in contenitori e supporti sopravvissuti a catastrofi, incendi, dispersioni. Poi il frammento è diventato un genere letterario, concepito sin dal principio in questa forma discontinua, ma mi piace pensare che, anche in questo caso, vi sia a monte una qualche forma sottaciuta di catastrofe. Un po’ come quando Sebald scrive in Austerlitz che edifici sovradimensionati «gettano già in anticipo l’ombra della loro distruzione e, sin dall’inizio, sono concepiti in vista della loro futura esistenza di rovine».
Inoltre potremmo pensare a un frammento come a un ologramma (quelle immagini tridimensionali di un oggetto ottenute attraverso l’impiego di raggi laser). Ogni parte di un ologramma ha la particolarità di contenere tutte le informazioni dell’ologramma intero. La parte contiene ed è il tutto. Il frammento è tutto.
Con Persona ho cercato di raccontare, o meglio, di presenziare a una storia che è una storia del presente. La forma frammentaria è quella che ho sentito più adatta per farlo. Tanto nella scrittura del testo quanto nella realizzazione delle immagini.
Ci sono alcune pagine in cui ho trascritto una serie di status e commenti raccolti su Facebook, una sorta di cut-up applicato al discorso collettivo che emerge dallo spazio pubblico social. Graficamente presento questi testi come una serie di onde che attraversano le pagine. Non ho utilizzato il copia-incolla, li ho trascritti lettera per lettera, come fossi io stesso a scriverli. L’impressione, riscriverlo e leggendoli di seguito, è che emerga un discorso continuo, ma pensato da chi, detto da chi?
Forse la scrittura del futuro sarà tutta frammentaria, rotta e dispersa dalla tormenta e dal fuoco. E chissà quale verità emergerà unendo i pezzi.
Una presenza molto forte nel testo è quella del buddhismo: il bardo, la meditazione, i monaci che accompagnano il corpo verso la morte, la ciclicità del vivere; e, per agganciarmi alla tua citazione, anche la consapevolezza dell’agire (in questo caso, dello scrivere).
La consapevolezza è “attenzione”. Le pratiche buddiste ci invitano costantemente all’attenzione: nel vivere e quindi nello scrivere così come nel leggere, ma anche nel morire.
Il Bardo Thodol, il cosiddetto Libro dei morti tibetano, letteralmente “la liberazione nello stato intermedio attraverso l’ascolto”, è un manuale per assistere e guidare il morente. Quando si muore, ci dice il Bardo Thodol, è possibile che la prima reazione sia l’incredulità, lo sconcerto, lo sgomento. Le esperienze di pre-morte ce lo confermano: si osserva il proprio corpo dall’alto e le persone vicino (i familiari al capezzale, i paramedici del pronto soccorso, i medici in sala operatoria…) e si cerca in ogni modo di comunicare la propria esistenza in vita. Ma si è morti – e del tutto impreparati a quello che sta per avvenire nello spazio intermedio del bardo (l’assalto dei demoni che cercheranno in ogni modo di ostacolare una buona rinascita o, nel casi più fortunati, la fine del ciclo delle reincarnazioni). La morte, infatti, è una cosa di cui, allo stato attuale, si cerca di parlare il meno possibile, preferendo pensare a come rallentare l’invecchiamento o addirittura estendere la vita oltre i suoi limiti biologici.
Ma la mia idea è che la vita elettrica – l’utilizzo degli spazi virtuali, la costruzione di una “second life” digitale – sia una forma di morte (così come una forma di morte e di esistenza fantasmatica sono da sempre le immagini). E che le piattaforme siano un “libro dei morti elettrico”, quel libro dei morti che la nostra civiltà tecnologica e a-mortale non ha voluto scrivere ma che si ritrova a edificare come “colosso terminale”.
In tal senso Persona è un libro dei morti, e come tale – è il mio invito e la mia speranza di autore – da leggere ed esperire con “attenzione”.
Nel susseguirsi delle pagine, mi sembra di notare che una particolare importanza sia attribuita a un lessico riguardante la vista e la memoria: sono questi i cardini dell'(in)esistenza?
Non so davvero se siano o – peggio ancora – quali siano i cardini dell’esistenza. Se lo sapessi non sarei qui, ma in un altrove beato.
Tuttavia, posso notare che vista e memoria, oltre a essere gli strumenti (non unici) con cui esperiamo e fissiamo la vita, sono anche le nostre funzioni più fragili e minacciate. Vista e memoria, oltre a essere sottoposte a un naturale, fisiologico decadimento, sono oggetto costante delle pressioni del mondo, del desiderio, della manipolazione, della bellezza, dell’orrore. La tecnologia ci permette e promette di potenziarle: possiamo vedere di più, possiamo ricordare di più e, tuttavia, più lo facciamo, più quello che vediamo e ricordiamo risulta distorto, frammentato, costruito e ricostruito.
Si stima che, in Italia, il numero di persone affette da demenza triplicherà entro il 2050.
Sul mio nuovo smartphone ho una funzione interessante: si chiama “Add me”, “Aggiungimi”. Posso fotografare una persona e poi chiedere a quella persona di scambiarci il posto e fotografare me. Lo so, nel vecchio mondo avremmo chiesto a un passante di farci una foto, ma il vecchio mondo è scomparso, sommerso come in un romanzo di Ballard. L’IA di Google unisce i due scatti e crea una foto unica (e può anche scegliere, tra i tanti scatti a raffica, quelli in cui sorridiamo). Tra alcuni anni ricorderò un momento che non è mai esistito: io e un’altra persona che stiamo accanto e sorridiamo. O forse quel momento esiste proprio perché la macchina me lo farà ricordare?
Mentre ti rispondo mi è arriva una notifica: sono i “ricordi del giorno”, di un lunedì di qualche anno fa. Scorro le foto, ho una scossa di nostalgia, un picco dopaminico. Alla fine della serie lo schermo nero dice: “Hai visto tutti i contenuti. Torna domani per nuovi ricordi”.
Sono questi i cardini della nuova (in)esistenza?
In uno dei frammenti di Persona, scrivi “Quel giorno, per la prima volta, ho perso la memoria di parecchi giorni […] Guardo le centinaia di foto scattate e non ricordo”: l’immagine non basta a sostituire la memoria, che io personalmente lego più a una creazione linguistica (il ricordo è tale perché trasformato in parola, in narrazione), e quello che mi arriva approcciando quest’opera, che per comodità continuo a definire romanzo transmediale, è una subalternità dell’immagine alla parola.
Lavoro con le immagini da molti anni come grafico e designer nel campo della pubblicità e del Web. La furia delle immagini, per dirla alla Fontcuberta, la loro sovrabbondanza e invasività crescente, è un fenomeno che subisco da tempo e a cui ho contribuito (in maniera, debbo dire, mai memorabile: in più considero la gran parte della produzione nel campo della comunicazione – che è sempre orientata a vendere prodotti e pensieri – del tutto insignificante). Ma non è certo un fatto privato: la convergenza di consumo e produzione ci ha trasformati tutti in “prosumer”. Consumiamo e produciamo immagini con un ritmo sempre maggiore: e tali immagini, che circolano in rete a velocità ultrasonica, non sono più presenze inerti che noi guardiamo, ma ordigni furiosi che ci soverchiano. Non più viste – troppe per essere realmente viste – sono loro stesse a guardarci. Già nel mio precedente libro Diorama, uscito per Il Saggiatore, avevo in qualche modo indagato la natura spettrale e pervasiva delle immagini.
Questo traspare anche in Persona. E inoltre le immagini nascono prima della parola. In principio è l’immagine: nella forma di serpente tracciata da un fulmine nel cielo, nei disegni creati ai primordi della specie sulla parete di una grotta… e tutte le volte che creiamo un’immagine per eternizzare un istante, per prolungare una presenza al di là della sua fine.
Enrico Bormida
Immagine in copertina: Alberto Burri, Catrame, 1950, CC BY-NC-SA 2.0, https://www.flickr.com/photos/mazanto/15962899516