Rombo, Esther Kinsky
(Iperborea, 2023 – Trad. Silvia Albesano)
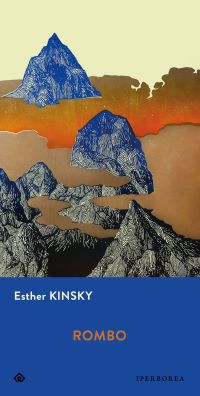 Per gli abitanti del Friuli il tempo, il paesaggio e la vita quotidiana sono stati divisi per sempre in due: un mondo prima e uno dopo il terremoto del 1976, un tempo prima e uno dopo il risveglio dell’Orcolat, il mostruoso gigante che, si dice, nel maggio di quell’anno ha fatto tremare la terra tutta. Rombo è il resoconto di quello sconvolgente e misterioso transitare dell’esistenza dal prima al dopo, evocato dalla testimonianza di sette abitanti di una valle all’estremo confine tra Italia e Slovenia che la sera del 6 maggio hanno visto il loro mondo squarciarsi e i loro luoghi cambiare per sempre. Luoghi che, adesso, possono tornare ad abitare solo attraverso il ricordo.
Per gli abitanti del Friuli il tempo, il paesaggio e la vita quotidiana sono stati divisi per sempre in due: un mondo prima e uno dopo il terremoto del 1976, un tempo prima e uno dopo il risveglio dell’Orcolat, il mostruoso gigante che, si dice, nel maggio di quell’anno ha fatto tremare la terra tutta. Rombo è il resoconto di quello sconvolgente e misterioso transitare dell’esistenza dal prima al dopo, evocato dalla testimonianza di sette abitanti di una valle all’estremo confine tra Italia e Slovenia che la sera del 6 maggio hanno visto il loro mondo squarciarsi e i loro luoghi cambiare per sempre. Luoghi che, adesso, possono tornare ad abitare solo attraverso il ricordo.
Esther Kinsky indaga le forme del ricordo nel legame tra uomo e natura in un romanzo corale che racconta il terremoto come trauma collettivo, attraverso testimonianze, leggende, racconti popolari, esposizioni scientifiche e saggi di geologia. Lo fa con uno sguardo delicato e poetico che getta luce sulle tracce, spesso effimere, che l’uomo lascia sul mondo e su quelle che la natura, viceversa, imprime sulla psiche umana. Con Rombo, la scrittrice, poeta e traduttrice tedesca Esther Kinsky ha vinto il Premio Kleist, è stata candidata al Deutscher Buchpreis ed è arrivata nella cinquina finalista del Premio Strega Europeo 2023. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la traduttrice Silvia Albesano, che ci ha parlato del suo rapporto con l’autrice, del suo lavoro di traduttrice e dell’approccio utilizzato per tradurre questo romanzo.
Di Esther Kinsky sono usciti, in Italia, tre libri, tutti tradotti da lei: Macchia, Sul fiume e Rombo. Cosa la ha avvicinata a questa autrice? Che rapporto avete?
Il mio primo incontro con Esther Kinsky è avvenuto attraverso la lettura di Macchia, nel 2018. A commissionarmela, per un parere, era stato l’allora editor per la narrativa straniera del Saggiatore, Andrea Morstabilini, che mi ha poi affidato anche la traduzione: non lo ringrazierò mai abbastanza. Quasi subito si è poi creato un rapporto diretto con l’autrice, molto attenta e interessata al processo traduttivo, essendo a sua volta traduttrice (dal polacco, l’inglese, il russo). Esther Kinsky mi ha invitato nella sua casa di Fagagna (UD), dove trascorre parte dell’anno: abbiamo parlato del libro, della sua scrittura, ma ci siamo anche osservate e studiate come persone. Ho avuto la sensazione che le premesse poter stabilire un rapporto di fiducia, all’interno del quale si è poi sempre dimostrata molto generosa (di spiegazioni, suggerimenti ecc.) ma anche estremamente aperta e rispettosa delle mie scelte.
Come descriverebbe Esther Kinsky per quanto riguarda la sua poetica, i suoi motivi e temi ricorrenti, se ce ne sono?
Più che dei semplici motivi ricorrenti, mi sembra di ravvisare nella sua opera dei forti e costanti nuclei di interesse, sostenuti da una ricerca formale mai fine a sé stessa e praticata con estremo rigore, come forma di conoscenza. C’è sempre uno sguardo scrupoloso, acuto, partecipe sulle persone, le circostanze e le condizioni delle loro vite, e la loro interazione con il paesaggio e i luoghi che abitano, spesso periferici o comunque mai considerati con la lente del cliché cartolinesco, idilliaco. E c’è una strenua ricerca linguistica per restituire ciò che quello sguardo coglie e dirlo con parole nuove, rigenerate da accostamenti non scontati, minimi slittamenti di significato, piccole deflagrazioni sommesse, date dalla giustapposizione di registri e varietà linguistiche non sempre contigui, che generano immagini potenti. Non va dimenticato che Esther Kinsky è anche poeta.
Veniamo a Rombo. Il libro è stato candidato al premio Strega Europeo 2023. In che senso, secondo lei, questo romanzo può considerarsi europeo?
Lo definirei un romanzo europeo perché scritto da un’autrice europea per appartenenza geografica, lingua, formazione, e focalizzato su una realtà europea, ma universale, come tutta la vera letteratura, per la profondità del respiro e la crucialità dei temi che affronta (il rapporto dell’uomo con il luogo fisico in cui si trova a vivere, la memoria e la costruzione del ricordo, e la forma che assumono le tracce del suo passaggio nel mondo).
Il titolo dell’edizione originale, in lingua tedesca, è Rombo, ed anche nelle traduzioni in altre lingue si è mantenuto l’uso di questo termine italiano. Considerando che, molto probabilmente, non è per mancanza di parole che traducono letteralmente il vocabolo, saprebbe motivare questa scelta?
Come il lettore scopre nelle prime pagine del libro, attraverso una citazione tratta da un manuale di geologia ottocentesco, «rombo» è la parola con cui in Calabria si indica il rumore inconfondibile che preannuncia e accompagna il manifestarsi di un sisma. Al tempo stesso, anche per chi non ne conosce il significato, è una parola molto evocativa per la sua componente onomatopeica: credo siano questi gli elementi che ne hanno incoraggiato la ripresa nelle varie traduzioni.
In Rombo non c’è una vera e propria trama: la struttura formale del libro si articola in brevi capitoli dove, alternativamente, prendono la parola sette personaggi che danno voce al trauma collettivo delle popolazioni vittime del terremoto. Per ogni testimonianza umana, poi, ce n’è di riflesso una geologica: Kinsky dà altrettanto (se non maggiore) spazio e rilevanza al paesaggio, descrivendo le valli, le rocce, i suoni degli animali che lo abitano – dimostrando, inoltre, un profondo senso pànico della natura, concepita come forza vitale, creatrice e distruttrice. Dunque, alla memoria umana col suo linguaggio simbolico, espressivo e immaginifico, spesso anche inadeguato, si accosta la memoria naturale, che si esprime attraverso un linguaggio scientifico molto ricco e attento, che nonostante presenti lessico tecnico risulta in qualche modo poetico e musicale. Come ha gestito la natura ibrida e peculiare di questo testo?
La difficoltà traduttiva principale nel conciliare le due voci – umana e naturale – presenti nel libro è data dalla peculiarità del lessico scientifico tedesco: botanico, ornitologico, geologico, prediletto da Esther Kinsky per il suo potenziale poetico ed evocativo e al tempo stesso anche molto accessibile, perché non derivato dal latino ma in gran parte autoctono (un esempio botanico tra tanti: l’euforbia si chiama Wolfsmilch, «latte di lupo»). In italiano, invece, un’immediatezza e un’espressività anche solo lontanamente analoghe si trovano spesso soltanto in varianti dialettali o regionali, comprensibili però a un numero più limitato di persone. E allora bisogna per forza di cose tentare di trovare compromessi e compensazioni, sperando che la poesia si sprigioni magari dagli accostamenti sonori, o dagli echi un po’ arcani e misteriosi di latinismi e grecismi.
È naturale, per me, accostare la figura della traduttrice o del traduttore all’immagine di un ponte, dal momento che col suo lavoro mette in comunicazione zone geograficamente e culturalmente lontane, rendendo possibile un arricchente scambio di voci e tradizioni. Lei come abita il ruolo di traduttrice?
Confesso che non ci penso mai in termini astratti: in prima battuta non mi percepisco come un tramite tra due lingue, due culture, due mondi, ma cerco il dialogo con un’altra persona o quanto meno un’altra voce, individuale, unica. E la premessa ineludibile, come in ogni dialogo, è l’ascolto: una delle dimensioni in cui, anche nella vita in generale, mi sento più a mio agio e trovo più gratificazione. La distanza spazio-temporale, linguistica e culturale dagli autori che traduco è un elemento di fascino, l’opportunità di misurarmi con qualcosa che è altro da me e schiude orizzonti più ampi, ma quell’alterità arriva sempre filtrata da una voce e un’individualità precise. Come ha scritto proprio Esther Kinsky nella prefazione a una sua raccolta di saggi sulla traduzione ancora inedita in italiano (Fremdsprechen, Berlin 2019): «l’uso della lingua è qualcosa di personale».
In questo particolare caso, poi, il ponte si fa bizzarro: parte da una zona remota dell’Italia, un’area al confine con la Slovenia che ha una sua cultura e una lingua propria, fatta di tante lingue d’altrove, per approdare dapprima in Germania e rientrare, infine, in territorio italiano, questa volta aprendosi alla penisola intera (linguisticamente parlando). Mi piacerebbe che commentasse questo processo di molteplici traduzioni: cosa può essersi perso e cosa, invece, si è creato? Che cosa può rappresentare, per lei, questo testo nel panorama culturale italiano?
La matrice linguistico-culturale slava degli abitanti del villaggio che Esther Kinsky sceglie come punto d’osservazione privilegiato è un elemento che nel testo tedesco è già cristallizzato e documentato attraverso singoli termini relativi a oggetti, strumenti musicali, personaggi del folklore ecc., che in quanto tali ho potuto riprendere e incastonare come semplici tasselli anche in traduzione. Di traduzione in senso stretto, quindi, parlerei solo per il passaggio dal tedesco all’italiano, in cui è stato possibile, da un lato, rinunciare a una serie di precisazioni e spiegazioni di servizio (che cosa voglia dire «Canin», per esempio, per noi è chiaro), e dall’altro beneficiare di uno sguardo esterno che, anche solo per il fatto di esprimersi attraverso un’altra sintassi, un’altra grammatica, un lessico dotato, come accennato in precedenza, di altre potenzialità, ci costringe a ripensarci e a ripensare alla nostra storia in termini meno prevedibili, e per molti versi più profondamente solidali e partecipi di quelli che ci riserviamo, spesso, tra connazionali.
Tema centrale del libro è quello della memoria. Kinsky sembra indagare il processo di costruzione della memoria in vari modi: penso alle testimonianze dei personaggi che tentano di ricostruire il momento della tragedia, e nel farlo riflettono su cosa sia un ricordo, dandosi risposte diverse e bellissime (il ricordo come ombra, come condanna, come insieme di frammenti, come lingua straniera impossibile da tradurre senza stravolgerne il significato); penso al paesaggio che muta e alla sua “inattendibile testimonianza”; penso, infine, ai passaggi in cui l’autrice descrive reperti fotografici, inserendo anche il racconto di come è avvenuta la scoperta della fotografia con gli esperimenti di Niépce, che hanno reso possibile questa altra forma di ricordo. Che ruolo ha, per lei, la letteratura nel processo di costruzione della memoria, e quale la traduzione?
Aiuto! Provo a giocare la carta della sintesi estrema, perché dubito di essere in grado di argomentare più diffusamente su una questione di questa portata. Penso che la letteratura sia memoria: che custodisca l’esperienza umana del mondo e degli altri e la interroghi, tenti di comprenderla, di intuirne o figurarsi un senso, di colmare i vuoti laddove parti di quell’esperienza individuale o collettiva non siano – o non siano più – accessibili direttamente, e che lo faccia convogliando il vissuto e il possibile in una forma. La traduzione è al tempo stesso – per necessità e suo malgrado – un filtro e un’amplificazione di quel tentativo.
Intervista a cura di Beatrice Palmieri
