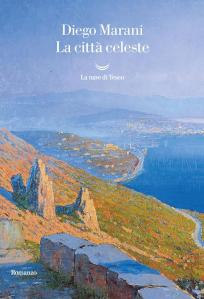Compie trent’anni esatti nel 2024 la carriera letteraria del ferrarese Diego Marani, scrittore eclettico e inafferrabile, forse il più insolito e originale del panorama italiano contemporaneo. Coltissimo e geniale poliglotta, il suo inimitabile percorso umano e professionale si snoda attraverso molteplici esperienze parallele: traduttore, interprete, ghostwriter, giornalista e saggista, prima di approdare alla narrativa. Per anni funzionario dell’Unione Europea (dove si è occupato di diplomazia culturale) e già direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi, Marani è addirittura l’inventore di un idioma artificiale, l’Europanto, lingua-gioco e provocazione contro il prevalente integralismo linguistico, nella quale agli albori del suo apprendistato di romanziere ha pubblicato in Francia la raccolta di racconti Les aventures des inspector Cabillot. Sempre in Europanto, ha tenuto per anni su diversi quotidiani stranieri una rubrica periodica di attualità e politica internazionale.
Quella di Diego Marani è una narrazione che racchiude in sé due anime divergenti, ancorché complementari. Da un lato, quella intimista e nostalgica, quando si abbandona al ricordo dei propri turbamenti adolescenziali tra la natìa Tresigallo e Ferrara, come in Vita di Nullo e Il compagno di scuola. È questa una nostalgia intesa come sentimento ambivalente, frutto di affetto ma anche di noia esistenziale, causata dal lento fluire del tempo tra le brume della Bassa Padana. È il rigurgito di un’umanità che non c’è più, ma soprattutto l’insofferenza per il grigiore e il provincialismo della città estense. Ed è ancora Ferrara ad ispirare il romanzo-pamphlet Il ritorno di San Giorgio, perfida satira che bacchetta l’inanità di politici, ecclesiastici e giornalisti.
Dall’altro lato, Marani descrive uomini in crisi identitaria, che vivono un’aspra e dolorosa condizione di sradicamento ed esilio, si crogiolano nella spasmodica e vana ricerca dell’altro e del diverso. In questa dimensione, lo scrittore ordisce tele paradossali, sorprendenti ed esotiche. La trama del racconto si fa allora diabolicamente e magicamente intricata come in L’ultimo dei Vostiachi. Oppure tragicamente e cerebralmente sublime come in Nuova grammatica finlandese. A questi ultimi due geniali romanzi in particolare, che gli sono valsi rispettivamente i premi letterari Grinzane Cavour e Stresa, è legato il successo tributatogli da pubblico e critica. Ma il risvolto forse più autentico ed originale che emerge da questi due capolavori è una vera e propria ossessione per l’etimologia e la lingua in ogni sua piega. Anzi, le lingue.
Ed è così che Marani, interprete di formazione (fluente in francese, inglese e olandese), approfondisce la conoscenza della lingua e della mitologia finlandese. Lo fa abbinando alla curiosità intellettuale un ascetismo glottologico mai fine a sé stesso, che diventa pretesto per raccontare drammi indimenticabili, paradossali e beffardi. Come quello del presunto Sampo Karjalainen, soldato ferito che in Nuova Grammatica finlandese perde la memoria e cerca di risalire alla propria vera identità sullo sfondo della seconda guerra mondiale che dilania Helsinki. O di Ivan, l’ultimo parlante di una lingua ugrofinnica siberiana e prova vivente della connessione tra il finlandese e la lingua dei nativi americani, antieroe e protagonista della rocambolesca satira noir L’ultimo dei Vostiachi.
Un capitolo a parte nella saga di Diego Marani, lunga trent’anni e ventitré tra romanzi e saggi, è rappresentato da La città celeste, epopea largamente autobiografica degli anni ruggenti dell’università e di una goliardia entusiasta, spensierata, che profuma di sogni e libertà. Ambientato in una Trieste vissuta come esilio-rifugio dall’ostile bassa padana e da un soffocante rapporto col padre, il romanzo riporta il protagonista sulle orme di Umberto Saba, poeta adorato, e Italo Svevo (cui peraltro ha dedicato il saggio A Trieste con Svevo). Scritto in pieno Covid, il libro ha la freschezza di un’opera prima, lo slancio di un neofita e una narrazione che lo distinguono dal resto delle opere dello scrittore per l’equilibrio maturo e l’atteggiamento finalmente risolto dell’autore.
Il tema dell’esilio, dello sradicamento, è un vero e proprio filone dei tuoi romanzi. Si tratta di un riflesso autobiografico per chi come te ha vissuto oltre quarant’anni fuori dall’Italia?
Non proprio, io non mi sono mai sentito esiliato né ho coltivato la nostalgia di una presunta terra felice da cui sarei stato strappato. Anzi ho sempre trovato nel diverso da me uno spunto, un arricchimento, uno stimolo a provare nuove vie. I personaggi dei miei libri vivono una condizione di esilio perché la loro patria non è un luogo ma un’idea, perché non vogliono appartenere ma essere liberi di scegliersi un’appartenenza molteplice. Quella che ho perseguito io nella mia vita, cercando sempre in ogni lingua, in ogni paese e in ogni cultura quello che mi piace e rivendicando la libertà di non appartenere a nessuno.
Con tuo padre hai avuto un rapporto ambivalente, tra l’adorazione e l’insofferenza. Come ha influenzato lo scrittore che sei diventato?
Ancora oggi non ho finito di scoprire quanto mio padre mi ha influenzato. Lo presi incondizionatamente come modello. Volevo essere come lui voleva, ma immancabilmente fallivo. Alla fine mi sono rassegnato ad essere me e basta. E mi sento ancora per questo imperfetto. Mio padre era una persona originale e uno spirito libero. Questo almeno da lui l’ho preso. Mi ha educato alla curiosità, alla scoperta, all’intraprendenza, anche alla trasgressione. Ma poi mi ha rimproverato di essermene andato da lui. Insomma, di avergli dato retta. Era anche un uomo duro, molto esigente con sé e con gli altri. È lui che ha incoraggiato la mia creatività, che mi ha sempre spinto a coltivarla, comunque si manifestasse.
Negli anni Ottanta a Trieste hai abitato a un portone di distanza da quella che era stata la residenza di James Joyce a fine Ottocento. Ne La città celeste, proprio come Svevo, finisci per fidanzarti con la sorella del tuo grande amore, dopo un corteggiamento fallito. Sono i segni del predestinato?
Dev’essere così. Ma a quei tempi non pensavo proprio che sarei diventato uno scrittore. I grandi autori triestini li veneravo e li consideravo inimitabili. Erano fra i pochi autori che rileggevo. Soprattutto Saba. Mi incantavano le sue descrizioni di Trieste, i suoi struggimenti così simili ai miei. Mi sono accorto quando c’ero già dentro che ero finito nella trama della Coscienza di Zeno innamorandomi della sorella del mio grande amore. Ma solo molto più tardi ho visto possibile una narrazione dei miei anni a Trieste. Solo scrivendo La città celeste mi sono accorto che la mia vita triestina era andata in scena nelle stesse strade di quella di Joyce, Saba e Svevo.
Parliamo di Ferrara e Tresigallo, dove sei nato. Alla tua terra hai dedicato diversi romanzi, ma la descrivi sempre grigia, provinciale, matrigna. In realtà, tu celebri con affetto gli anni dell’adolescenza, ma sempre con un’amarezza di fondo…
Non mi è piaciuta l’adolescenza. L’ho vissuta male e assieme a lei i miei anni di liceo. Se potessi, vorrei ripeterli tutti. Mi è mancata la passione per qualcosa che mi guidasse in quegli anni di trasformazione. Ma forse non poteva essere altrimenti. Io ero troppo eccentrico per quella provincia e anche in questo mio padre ha avuto un ruolo. Lui mi aveva addestrato all’originalità, alla libertà di pensiero ma la provincia italiana degli anni Settanta vedeva con sospetto chi si smarcava dai comportamenti conosciuti. A 14 anni avrei voluto un motorino, per andare in discoteca con i miei amici. Mio padre invece mi regalò tutta l’attrezzatura per camera oscura, perché coltivassi il mio interesse per la fotografia. Così io giravo in autostop da solo e scattavo foto che poi stampavo sempre tutto solo nella mia camera oscura. Ho coltivato anche lì l’arte del narrare mettendo insieme storie attraverso le immagini. Inquadrare era impostare una storia. Se ci badi, i miei libri sono molto “cinematografici”. Però, alla fine, alla provincia sono affezionato. Oggi è tutta cambiata, storpiata dalla modernità. Provo nostalgia per la vita di paese di allora, dove ci conoscevamo tutti e fra noi c’era un affiatamento ancor più forte dell’amicizia. Eravamo una tribù e quella familiarità con i compaesani non l’ho mai più sperimentata altrove.
L’attenzione maniacale per la lingua, per la parola ti avvicina a un mostro sacro come Umberto Eco. Lui grande semiologo e latinista, tu fine linguista e poliglotta. Il richiamo ti spaventa?
Eco lo conoscevo. Gli era piaciuto il mio gioco dell’Europanto e ci scherzavamo insieme. Era una persona molto più abbordabile di quanto si pensi. Ma certo io non ho nulla dell’accademico che era lui. Eco era uno studioso, uno scienziato. La mia passione per la lingua invece è sempre stata empirica. Mi è sempre piaciuto sentirmele in bocca le lingue e parlandole entrare in mondi sconosciuti. A cominciare dal mio dialetto che pratico correntemente e che è stato per me la mia prima lingua straniera.
Nuova grammatica finlandese e L’ultimo dei Vostiachi sono i tuoi libri consacrati e forse più apprezzati dalla critica. Come nasce la tua passione per la cultura finlandese? E come nascono due trame così originali?
Nel finlandese ci sono caduto dentro per caso. Allora ero traduttore. La Finlandia aderiva all’UE e servivano traduttori che imparassero il finlandese. Il mio capo cercava volontari e io ero troppo giovane funzionario per dire di no. Così ho imparato la lingua con corsi annuali e diversi soggiorni in Finlandia che mi hanno fatto scoprire un paese diversissimo da quel che credevo, con una cultura molto particolare e una storia tragica. La lingua poi è un affascinante rompicapo, una specie di introduzione all’Asia con una struttura che cambia anche il modo di pensare. Quanto alle mie trame, mi sono sempre sforzato di porre al centro della mia scrittura la trama. Aborrisco i romanzi che vanno avanti alla cieca, senza una storia. Anche io ho scritto romanzi dove la trama è solo una scusa per svolgere un pensiero. Ma sempre trama deve esserci. Considero la trama un segno di rispetto per il lettore e anche l’essenza del romanzo.
Tu hai frequentato la politica da punti di vista diversi. Hai fatto il giornalista e il commentatore su quotidiani stranieri. Poi sei stato assistente del ministro Dario Franceschini. Infine ghostwriter del presidente della Commissione UE José Barroso, socialista, e del presidente del Parlamento UE XXX Tajani di Forza Italia. Come si riesce a svolgere ruoli così diversi e a conciliare personalità di orientamenti così lontani?
Anche questo è un romanzare. Per scrivere discorsi bisogna mettersi nei panni di chi li deve pronunciare come per scrivere romanzi bisogna immedesimarsi nei personaggi della storia. Ed è molto divertente entrare nella testa di gente diversa. In un certo modo apre la mente… Scrivere discorsi mi piaceva molto ma a volte dovevo stare attento a non travasarci troppo il mio pensiero. C’erano comunque sempre direttive molto nette su quello che si doveva scrivere. Una cosa divertente era trovare la citazione giusta per l’occasione che fosse anche consona al personaggio. Ne avevo un repertorio che arricchivo con le mie letture. Frequentando persone importanti poi si ha sempre l’opportunità di influenzarle. Le più intelligenti mi ascoltavano perché capivano che un punto di vista fuori dalla mischia poteva essere loro utile. Lì sta la forza del bravo politico.
Dopo l’intermezzo universitario a Trieste, hai passato quarant’anni della tua vita all’estero parlando svariate lingue straniere. Ti senti sempre uno scrittore italiano?
No, non mi sono mai sentito uno scrittore italiano. Ho sempre avuto l’impressione di avere di italiano soltanto la lingua. Le mie tematiche sono molto diverse da quelle più in voga in Italia. Del resto ho anche l’impressione di non essere considerato pienamente italiano neppure dalla critica. Io vivo lontano dal mondo culturale italiano, frequento di più quello franco-belga, anche quello britannico. Leggo molto poco di letteratura italiana. Non per scelta, ma per caso, perché trovo più facilmente a portata di mano autori della parte d’Europa dove vivo.
La città celeste è il tuo romanzo della maturità. Eppure, nel ricordare Trieste e la goliardia, lo pervade l’entusiasmo del neofita, sembra quasi un romanzo d’esordio. Dopo il pensionamento hai trovato casa proprio a Trieste. È lì che ti senti uno scrittore e un uomo risolto?
Sono tornato a Trieste consapevole del fatto che non vi avrei ritrovato i miei vent’anni ma anche certo che vi avrei trovato le suggestioni di quando la scoprii per la prima volta. Di fatto io non ho mai lasciato Trieste. L‘ho sempre frequentata in tutti questi anni almeno un poco ogni tanto. A Trieste ho scoperto la fecondità della frontiera, che separa ma anche mescola mondi diversi, che divide e così facendo mostra l’assurdità della divisione. La frontiera cela l’identità che mi è più consona, quella del miscuglio, dell’incontro, dove nulla è netto ma tutto e mobile, cangiante. Dove la verità non è mai una ma tante. A Trieste conto di passare un po’ del mio tempo a coltivare meglio la mia conoscenza della città e delle sue terre e anche a coltivare il nume del ricordo, tanto propizio alla scrittura. La città celeste è davvero un romanzo d’esordio. Ce l’avevo in testa da decenni ma mi mancava la serenità di pensarci. L’ho trovata quando papà è morto. Lì mi sono sentito libero di parlare di lui. Perché la mia storia con Trieste comincia con la separazione da mio padre.
La città celeste è anche un omaggio intimista e affettuoso a Saba e Svevo. A chi ti senti più vicino? Chi ti ha influenzato di più?
Non saprei dire esattamente. Forse in Saba mi sono ritrovato di più quanto a struggimenti. Le sue poesie potrebbero essere la colonna sonora dei miei amori giovanili. Ancora oggi le cito a memoria. Svevo invece mi è sempre stato simpatico come personaggio, scrittore per caso o per sbaglio, un poco sornione, furbastro e autentico triestino. Di lui mi è sempre piaciuto molto il distacco da tutto, la sua indipendenza intellettuale, il suo non essere in fin dei conti uno scrittore italiano.
Sarà il 2024 l’anno del tuo libro numero ventiquattro?
Esce in autunno. Ma non ho ancora un titolo.
Dopo trent’anni di carriera letteraria, è tempo di bilanci. La critica ti considera uno scrittore per palati fini. È una collocazione che ti lusinga o preferiresti essere più popolare?
Il tragico di ogni scrittore è che non può scegliersi il pubblico ma da questo viene scelto. Credo dunque di avere il pubblico che mi merito. Ma credo anche che nessun vero scrittore pensi al pubblico quando si mette a scrivere. Scrivere è un’impellenza, un bisogno, un richiamo a cui non si può resistere. Inevitabilmente mi procuro i lettori che sentono quel che sento io scrivendo e che condividono il mio interesse per le mie tematiche. La mia non è una scrittura difficile, ho uno stile molto lineare e pulito ma i miei argomenti sono poco comuni. Non mi piace raccontare vite vissute. Preferisco inventare storie che esprimano un’idea, che sviscerino una questione, che peschino nella profondità. Ultimamente sto approfondendo le mie riflessioni sul senso dello scrivere, sul ruolo che può ancora avere la scrittura nel mondo attuale. I mezzi espressivi dell’immagine oggi stanno spiazzando la scrittura. Ma ci sono cose che solo con lo scrivere si esprimono pienamente e quelle cerco io di dire con la mia scrittura.
a cura di Marco Lodi Rizzini