La Nottola è una rubrica curata da Stefano Vernamonti.
Racconta libri rimasti nascosti, nelle penombre della cultura, o al di fuori delle “novità editoriali”.
Arpagoniana, Konstantin Vaginov
(Voland, 1996 – trad. it. Donatella Possamai)
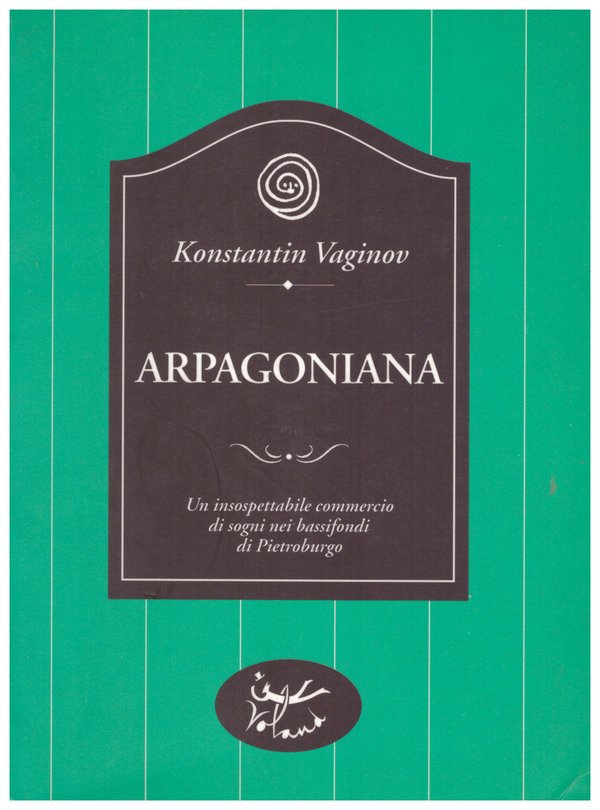
Nel 1933, lo scrittore e poeta Konstantin Vaginov consegna un dattiloscritto alla “Casa editrice degli scrittori a Leningrado”. Successivamente, su consiglio di Nikolaj Tichonov – uno dei più grandi poeti russi degli anni Venti – Vaginov si fa rendere il testo, al fine di apportare delle modifiche con lo scopo di mettere maggiormente in evidenza le tematiche sociali della sua opera. La tubercolosi, tuttavia, non gli consentirà di completare la revisione dell’opera: Vaginov ne morirà, a Leningrado, nel 1934.
A raccontare brevemente questa storia sono le prime righe della postfazione ad Arpagoniana, il titolo che Vaginov – poeta del gruppo OBERJU, avanguardia futurista sovietica – scelse per la sua opera e che la casa editrice Voland ha pubblicato in italiano nel 1996, basandosi sulla redazione originaria del testo da parte del suo autore. La sua prima pubblicazione era avvenuta soltanto nel 1983 negli Stati Uniti – basandosi però sulla seconda e incompiuta redazione del romanzo – dato che la vedova non riuscì a farlo pubblicare in patria. Ma bando agli indugi.
Un uomo si aggira per un mercato di robivecchi. Tra lime arrugginite, bottoni, vecchi stemmi, l’uomo contratta e commercia, cercando di accaparrarsi da mercanti improvvisati e disperati degli oggetti che poi rivenderà a qualcun altro a un prezzo superiore, in modo tale da mettere assieme abbastanza soldi per poter andare a ubriacarsi. Insomma, una giornata come un’altra negli allucinati e labirintici bassifondi di Pietroburgo. C’è però una merce particolarmente pregiata agli occhi di Anfert’ev, non solo perché non si trova spesso tra i mercati che bazzica famelico, ma soprattutto perché conosce un acquirente che ne difetta in modo particolare, e che paga molto bene per averne: sogni.
“- Di sogni, tu, nonna, ne fai tanti? – Chiese Anfert’ev camminando accanto alla vecchietta.
– Ah tesoro, ma io sogno quasi ogni giorno. Faccio dei bei sogni io, proprio belli!
– E tu nonna, raccontali a me. Perché mai raccontarli sulla panchina davanti a tutti. Loro non ti danno niente e io invece ti pagherò cinque copechi per ogni sogno. Te li comprerò […].
– E a te a che cosa ti servono i sogni, – chiese la vecchietta – cos’è, te li rivendi più cari? Non ho mica mai sentito niente di questo commercio.
– Ce ne sono di cose che non hai mai sentito, nonnetta – rispose Anfert’ev – il sogno è una merce come le altre, solo bisogna avere il compratore!”.
Un business, se non in piena regola, sicuramente ben organizzato, con tanto di listino prezzi:
“Vita d’oltretomba, sogno della balia. Rubli 1. Piano quinquennale, sogno della mercantessa attempata. Rubli 2. La ragazza e l’atteggiamento gentile degli orsi nei suoi confronti, sogno della bibliotecaria. Copechi 50”.
Lokonov è invece un uomo che non riesce a sognare; neanche da sveglio. Non riesce più a immaginarsi una vita migliore di quella che conduce, dopo aver sprecato le infinite possibilità che ogni giovinezza spalanca: trentacinque anni, senza stipendio, a carico della madre infermiera e con il suo cuore abitato da una fanciulla che può solo seguire da lontano, mentre lei cammina e sorride sottobraccio a un uomo sconosciuto. La parabola di Lokonov sembra richiamare, in uno splendido chiasmo letterario, il sognatore delle Notti Bianche di Dostoevskij: da un lato un sognatore bulimico che vive un attimo di beatitudine nel suo effimero incontro con Nasten’ka, e dall’altro un uomo incapace di sognare, immerso senza soluzione di continuità in un immobilismo esistenziale la cui causa, Julia, si rivelerà forse meno irraggiungibile di quanto immaginava. A intrecciare il filo di questo chiasmo, il ruolo topico del sogno come fuga dalla realtà:
“- È molto semplice. Lei voleva staccarsi dai suoi sogni, inserirsi nella vita reale, legarsi in qualche modo alla sua vita, ebbene, non le è riuscito. Torni di nuovo ai suoi sogni.
– Lei è ubriaco! – disse Lokonov. – Come osa ficcare il naso nella mia vita privata?
– La vita privata, il sacro diritto di proprietà! E chi mi ha proibito di ficcarci il naso: le usanze della vecchia società? Ci sputo sopra […] a che cosa le serve una ragazza? Cosa potrebbe offrirle? La ricchezza spirituale del millenovecentododici? Fondi di magazzino, acquirenti non se ne troveranno di sicuro! Sogni di una vita bella, neanche quelli possiede! Vedute giovanili, non ha nemmeno quelle! Mi dica, che cosa possiede? Lei non ha niente da offrire. È meglio che neanche ci pensi all’amore”.
Anfert’ev e Lokonov non sono però i veri protagonisti di questo piccolo romanzo, e forse non lo sono neanche i sogni. Perché attorno a loro si intrecciano le vicende di molti altri personaggi come l’ingegner Toropulo, Žulonbin, Punševič. Tutti stretti in centocinquanta pagine e accomunati da una precisa caratteristica: l’accumulo compulsivo di oggetti inutili, senza valore. Non solo perché il commercio nella Russia stalinista è bandito in quanto pratica reazionaria, ma proprio per la tipologia di oggetti collezionati: cartine di caramelle, scatole giapponesi di fiammiferi, foglie e fiori secchi, mozziconi di sigaretta, unghie persino, fino ad arrivare ai sogni. Tutti loro sono in qualche modo i protagonisti di Arpagoniana, generatori perpetui di digressioni all’interno del romanzo, il quale davvero “suggerisce l’immagine di uno stecchito alberello natalizio che sta per crollare sotto il peso delle rutilanti decorazioni che pendono a decine, a centinaia dai rami esili e malconci”. La trama è in effetti piuttosto debole e sconclusionata, ma a compensare c’è la prosa di Vaginov che fa di questo romanzo quasi una pièce nel suo essere così teatrale – nel senso letterale della parola, nella sua capacità di disegnare con poche frasi, all’inizio di ogni capitolo, uno spazio e una tonalità emotiva all’interno dei quali i dialoghi dei personaggi si inseriscono fitti, serrati, davvero vividi e solo raramente inframmezzati da piccoli cambi di scena e brevi riflessioni interiori.
Non è del resto un caso se il romanzo prende il nome da Arpagone, il celebre padre padrone della commedia L’avaro di Molière. Per due motivi: il primo è certamente il fatto che la figura di Arpagone sia il prototipo del “pitocco”, cioè dell’avaro che pone le sue ricchezze al di sopra di ogni cosa. Il secondo motivo risiede nel fatto che è in più un tipo molto specifico di pitocco: come ha scritto Ventura nel suo La teoria della classe disagiata, nell’Avaro la rivalità sessuale si sovrappone a quella economica – poiché padre e figlio desiderano la stessa donna e devono lottare per lo stesso capitale – e perciò la donna rappresenta nella commedia “un sostituto simbolico della ricchezza. Una sineddoche: la parte per il tutto”. Allo stesso modo, in Arpagoniana, le collezioni di oggetti senza valore sono la sineddoche di un mondo ormai sepolto dalla Rivoluzione e dallo stalinismo, che gli strani pitocchi del romanzo cercano invano di sublimare, di trattenere, di sognare:
“- Ed ecco, in realtà, cos’è che resta, quando raggiungiamo il quarantesimo o anche il trentacinquesimo anno d’età, di quella donna e di quella meravigliosa Italia. Si trasformano in sogno, e noi cominciamo a pensare che il mondo intorno è cattivo e vile, e il magnifico canto dell’usignolo si trasforma per noi in una passionale canzonetta”.
Stefano Vernamonti
