Avventura dell’uomo, Piero Scanziani
(Utopia, 2020)
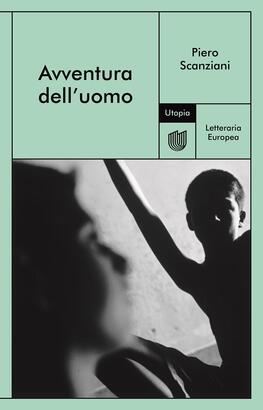
C’è una casa editrice, fondata in pieno lockdown da giovani professionisti: Utopia. Con uno stile grafico intrigante, d’ispirazione adelphiana ma comunque elaborato in maniera propria, e un catalogo nel quale trovano spazio grandi autori del Novecento scomparsi dalle librerie (Bontempelli, i Nobel Sigrid Undset, Josè Cela, prossimamente – e finalmente – Grazia Deledda) e voci contemporanee da tutto il mondo (tra le future pubblicazioni, scrittrici dalla Danimarca, dal Brasile, dalle Mauritius), Utopia è entrata di prepotenza nell’editoria italiana. Tra le recenti pubblicazioni, figura anche Avventura dell’uomo di Piero Scanziani, scrittore elvetico di lingua italiana che Mircea Eliade aveva candidato per due volte al Premio Nobel.
Di molti libri è difficile dare una definizione di genere, ma vale ancor più per quest’opera che non è romanzo e non è saggio: una prosa di non fiction, diciamo così, in cui a essere narrata, in tutta la sua complessità e meraviglia, è la vita umana. Resta difficile anche definirne i confini disciplinari: non è filosofia e non è antropologia, non è biologia e non è psicologia, che pure ricorrono talvolta con diverse incursioni. Vagamente può ricordare l’etologia di Eibl-Eibesfeldt e Desmond Morris in una chiave più letteraria e poetica. Il padre dell’etologia umana da una parte e l’autore della Scimmia nuda dall’altra condividono il comune intento di raccontare l’essere umano come fosse altro, come una specie animale da osservare, studiare e indagare – non a caso entrambi hanno una formazione zoologica. L’uomo viene così privato della sua umanità per diventare oggetto scientifico, per essere altro dall’osservatore, come se chi analizza e chi è analizzato appartenessero a regni diversi. In questo modo si cerca di coniugare sociale e biologico, di rendere il più possibile esatto e scientifico ciò che per definizione tale non è.
L’intento di Scanziani può dirsi simile: egli però osserva l’uomo in quanto altro come chiunque di noi possa osservare un’altra persona riflessa nello specchio. Scanziani è osservatore ed osservato insieme, e indaga l’uomo puro, all’infuori di ogni coinvolgimento culturale e sociologico, con gli strumenti propri della Letteratura. L’uomo in quanto nuda vita: una vita così particolare, complicata e diversa da quella di qualsiasi altro essere vivente. Il racconto, intervallato sempre da piacevoli digressioni (da Mendel alla vita dei cristalli), lascia una sensazione di beatitudine, che deriva da una ritrovata consapevolezza: la nostra esistenza è più bella e speciale di quanto credessimo. In questo senso, la sua lettura può dirsi consolatoria.
Scanziani ci racconta l’avventura dell’individuo umano sin dal grembo materno, con una narrazione letteraria e un tono venato di candore e d’incanto. Al principio c’è il rapporto con tutti i nostri antenati, dai nonni fino al primo avo contemporaneo della glaciazione, e da tutti abbiamo ereditato qualcosa, anche solo una piccola componente genetica. E con essa, ciascuno di loro continua a vivere in noi e a determinare il nostro destino. «Erano tutti lì, con le mani piene d’offerte intorno al nostro sonno e, pur scomparsi da secoli, ognuno di essi aveva qualcosa da imporre. Nemmeno sepolti da mill’anni gli uomini accettano d’essere totalmente morti.» L’avventura dell’uomo è al tempo stesso l’avventura di tutti gli uomini prima e dopo di lui, come se in ciascuno di noi fosse custodita una riproduzione in scala dell’intera umanità. «Intorno al nostro sonno embrionale s’affollavano quasi tutti gli uomini che nei millenni hanno sudato e quasi tutte le donne che hanno partorito sulla Terra, a cominciare da Eva.»
Avventura dell’uomo è stato scritto alla fine degli anni ’50, ma, a dispetto del nome e in avanguardia rispetto al tempo, è sempre l’avventura dell’uomo così come della donna. Lontano da qualsiasi inciampo in una retorica fallocentrica, che sarebbe stato comune per l’epoca, Scanziani non fa corrispondere mai umanità e uomo: i capitoli sull’adolescenza, sulla maturità, sull’invecchiamento sono sempre scissi nella doppia prospettiva, ognuna distinta per le proprie specificità. «L’avventura umana non è solamente l’avventura maschile; è insieme l’avventura dell’uomo e della donna. Ad entrambi e ad ogni momento la vita chiede forza e chiede amore.»
Per tutta l’opera Scanziani intona un elogio alla donna, a cui rivolge una riconoscenza e una venerazione quasi religiosa, perché nel suo essere madre c’è qualcosa del sacrificio. «Quando giunge l’ora di nascere, giunge l’ora di soffrire. Per nove mesi nostra madre ha portato intero il peso e sofferto per noi.» «Giunti in quel ventre, noi ci siamo espansi con un egoismo illimitato. Abbiamo suscitato nella donna che ci portava appetiti nuovi e ineluttabili, stravaganti. L’avviamo imbruttita macchiandole il viso e deformandole l’addome. L’abbiamo intossicata fino al vomito e allo svenimento. Le abbiamo imposto sonnolenze irresistibili e tristezze inconsolabili […] pronti com’eravamo ad ucciderla, pur di nascere e vivere.»
Seguiamo poi l’individuo umano crescere, scoprire il mondo, formare la propria identità, conoscere l’amore e creare famiglia, maturare, invecchiare, e per ogni fase della vita, affrontarne i travagli e le gioie, i mutamenti dell’animo e ogni nuova consapevolezza. Egli si avvia così alla sua fine, guardandosi indietro, rifugiandosi nel passato e chiedendosi il perché di tutto quanto ha vissuto. L’uomo è l’unico tra le specie viventi a conoscere un lento, progressivo e inesorabile invecchiamento; l’unico a sapere d’essere condannato un giorno a morire.
Nei capitoli finali, come in quelli iniziali, probabilmente Scanziani riesce a esprimere il meglio. Non c’è nulla di terribile e di funereo nella sua concezione della morte. «Morire è meraviglioso, un’intensa felicità» dice con le parole di Prezzolini. Quella dello scrittore vociano è solo una delle esperienze riportate dall’autore di persone che sono state sul punto di raggiungere la morte e poi sono tornate alla vita. Tutti loro – come anche Carl G. Jung – raccontano di un intenso benessere, di un’esperienza extracorporea, di una contemplazione della propria intera esistenza. Scanziani vuole dimostrare così che il trapasso non è fine, ma l’inizio di un’esistenza ulteriore, perché a morire è il corpo, non l’anima, e «l’uomo, che si crede un corpo, è invece un’immensità». La spiritualità di Scanziani, pur di ispirazione cristiana, si presenta qui come una spiritualità cosmica, universale, che non riecheggia di una esplicita retorica religiosa, piuttosto di una più generica concezione escatologica e teleologica dell’esistenza, per cui «ogni uomo che appare sulla Terra ha il suo proprio destino, perché ha la propria ragione».
Ripercorrendo la storia umana a partire dalla procreazione, dalla formazione della vita nel grembo materno e dall’incanto dell’infanzia, Avventura dell’uomo sembra riportarci proprio a quegli anni di incosciente beatitudine, quando tutto ci entusiasmava e tutto ci appariva meraviglioso, perché ancora non eravamo assuefatti alla vita. Scanziani allora sgombra la nostra concezione dell’esistenza da ogni assuefazione e abitudine, per mostrarci un’immagine che avevamo dimenticato: quel che ormai ci è diventato ovvio – avere un corpo che funziona come macchina perfetta, partecipare al gioco del mondo e al succedersi delle generazioni, essere vita – ecco che di nuovo ci appare incantevole. Scanziani fa sentire il lettore protagonista di una storia incredibile e di un prodigio miracoloso, per il solo fatto d’essere umano.
Giuseppe Rizzi
Immagine in anteprima: foto di Charles Tumiotto per Unsplash

Davvero interessante e originale; sia il libro che la Casa Editrice. Buono a sapersi. Grazie per la segnalazione.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie, Stefano
"Mi piace""Mi piace"