Piante che cambiano la mente, Michael Pollan
(Adelphi, 2022 – Traduzione di Milena Zemira Ciccimarra)
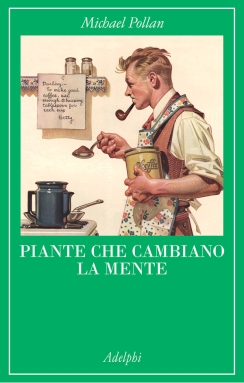 L’interesse editoriale per il mondo delle sostanze psicoattive sembra aver subito una drastica impennata negli ultimi anni, tanto che si è tornati a parlare del cosiddetto “Rinascimento psichedelico”, un termine con cui si intende la riscoperta del potenziale curativo e terapeutico di alcune sostanze psichedeliche da parte della comunità scientifica. Non è difficile infatti scovare nelle librerie esempi di questo rinnovato interesse, che non ha risparmiato né piccoli né grandi editori. Si inserisce in questo filone anche l’ultimo lavoro di Micheal Pollan, Piante che cambiano la mente, in cui l’autore torna su un tema a lui caro (e già parzialmente affrontato in Come cambiare la tua mente), concentrandosi però maggiormente sul rapporto che l’essere umano ha con le piante da cui derivano le sostanze psicoattive.
L’interesse editoriale per il mondo delle sostanze psicoattive sembra aver subito una drastica impennata negli ultimi anni, tanto che si è tornati a parlare del cosiddetto “Rinascimento psichedelico”, un termine con cui si intende la riscoperta del potenziale curativo e terapeutico di alcune sostanze psichedeliche da parte della comunità scientifica. Non è difficile infatti scovare nelle librerie esempi di questo rinnovato interesse, che non ha risparmiato né piccoli né grandi editori. Si inserisce in questo filone anche l’ultimo lavoro di Micheal Pollan, Piante che cambiano la mente, in cui l’autore torna su un tema a lui caro (e già parzialmente affrontato in Come cambiare la tua mente), concentrandosi però maggiormente sul rapporto che l’essere umano ha con le piante da cui derivano le sostanze psicoattive.
Il saggio è infatti strutturato in tre sezioni, ognuna delle quali ricostruisce la storia di una pianta che produce una particolare sostanza, adottando un punto di vista storico, scientifico e antropologico. L’interesse dell’autore non è solo quello di descrivere e comprendere gli effetti che tali piante hanno sulla nostra mente, ma il suo scopo sembra essere piuttosto quello di inserire il discorso sulle cosiddette “droghe” in un contesto che abbracci anche la dimensione storica e sociale.
Questo è particolarmente evidente nella sezione iniziale del libro dedicata all’oppio, il cui primo capitolo consiste in un saggio che Pollan scrisse venticinque anni fa, quando il governo di Clinton era impegnato in una durissima guerra alla droga. Era stato però Nixon ad inaugurare questo “conflitto”, per motivi che non sembravano avere nulla a che fare con la salute pubblica: tramite leggi durissime che punivano il possesso e consumo di alcune sostanze l’ex Presidente degli Stati Uniti poteva in realtà fare piazza pulita dei suoi principali oppositori, ovvero la sinistra anti-militarista e i neri[1].
Verso la fine degli anni ‘90, quando le leggi antidroga sembravano assumere un carattere sempre più draconiano, Pollan decise di provare a coltivare nel proprio giardino diverse piante di papaveri di oppio, e in breve tempo si ritrovò in una spirale di paranoia e auto-censura dai toni quasi comici, ma che rendono perfettamente l’idea delle contraddizioni di quel periodo, in cui «un atto del tutto ordinario e senza colpa come lanciare una manciata di semi comuni e perfettamente legali poteva in qualche modo trasportarti nel paese della criminalità».
L’aspetto più agghiacciante di questo saggio risiede proprio in questo: comprare e vendere semi di papavero non sembrava essere illegale, e nemmeno avere qualche fiore nel proprio giardino, ma solo a patto che non si avesse la consapevolezza che dalla capsula di quel fiore si potesse estrarre l’oppio.
«È come se fosse previsto un limite di trenta chilometri all’ora che non è mai stato affisso, mai fato rispettare, di cui non si è mai nemmeno parlato, (…) poi scelgono uno e gli dicono: ehi, stavi andando a ottanta all’ora. (…) Hai infranto la legge, finirai in prigione! Ma non state fermando nessun’altro, dici tu. Non importa, questa è la legge ed è a nostra discrezione» (p. 70)
La seconda parte del saggio è invece dedicata ad una sostanza che la maggior parte di noi assume ogni giorno, ovvero il caffè. Probabilmente quasi nessuno considera la caffeina come una droga, ed è per questo straniante vederla associata all’oppio e alla mescalina; eppure quello che dimostra Pollan è proprio questo: non c’è una grossa differenza tra il potere allucinogeno della mescalina e quello stimolante del caffè, perché tutte e due consistono in un’alterazione del normale stato di coscienza. Senza considerare poi che, al contrario della mescalina, la caffeina crea dipendenza («Cosa ne era stato del mio proposito di bere caffè solo il sabato? Poi sentii una voce che diceva: Ma è ancora sabato! Capii subito chi era: la voce del tossicomane!» p.166).
Da questo punto di vista è interessante l’esperimento che l’autore fa su sé stesso, decidendo di astenersi dal consumo di caffeina per l’intera durata del processo di stesura del saggio. Se in un primo momento l’effetto dell’astinenza sembra solo consistere in una sorta di annebbiamento, man mano che il tempo va avanti Pollan si rende conto di quanto quello che lui credeva fosse il suo stato normale di coscienza fosse in realtà in parte alterato dalla “tazza di ottimismo” che era solito bere. L’esperienza della prima razione di caffè dopo mesi di astinenza è poi per Pollan qualcosa di talmente forte da fargli esclamare: accidenti, questa roba è legale?
Adottando poi una prospettiva storica, Pollan ricostruisce il rapporto tra la caffeina e l’evoluzione del pensiero occidentale, dimostrando l’enorme impatto che questa “droga” ha avuto sulla mente umana:
«Tè e caffè inaugurarono una trasformazione del clima mentale, acuendo menti che erano prima annebbiate dall’alcol e liberando le persone dai ritmi naturali del corpo e del sole, così da rendere possibili tipi del tutto nuovi di lavoro e, molto verosimilmente, anche nuovi tipi di pensiero» (p.118)
Il rovescio della medaglia è però vagamente inquietante: se da un lato il caffè ci ha reso più produttivi e vigili, dall’altra ha in qualche modo alterato i nostri ritmi biologici. Il funzionamento della molecola della caffeina è infatti piuttosto subdolo, perché nasconde l’effetto di un’altra sostanza psicoattiva, fondamentale per il funzionamento del nostro sonno, ovvero l’adenosina, che continua tuttavia ad accumularsi nel nostro corpo man mano che passano le ore. Bevendo caffè ci sembra di essere meno stanchi, ma in realtà lo siamo sempre di più, e questo risulta spesso in un peggioramento della nostra qualità del sonno («La maggior parte della caffeina che viene consumata oggi serve a compensare il pessimo sonno causato dalla caffeina» p.151).
Infine, la terza sezione del libro è dedicata alla mescalina contenuta nei cactus San Pedro e Peyote e ai rituali che sono collegati a tale sostanza. In questa parte, anche il ritmo di scrittura utilizzato da Pollan cambia, adattandosi in qualche modo all’argomento trattato e facendosi più fluido e rilassato. Questa è la sezione del libro in cui emerge di più lo sguardo antropologico dell’autore, perché la sostanza di cui si parla è una parte fondamentale delle culture dei popoli indigeni dell’America del Nord. Per questi ultimi, che la considerano come una vera e propria religione. Un aspetto interessante è anche quello legato al potere curativo della mescalina, un potere che sembra interessare soprattutto l’aspetto psicologico. Dopo diverse peripezie, Pollan riesce finalmente a partecipare alla cerimonia de wachuma (altro nome del cactus San Pedro) e in quell’occasione si rende conto di come questo tipo di esperienze abbiano un effetto che coinvolge sia l’aspetto individuale che quello collettivo:
«L’effetto congiunto di quei suoni era trascinante, e favoriva uno stato mentale che mi aiutò a comprendere meglio il potere delle cerimonie di medicina: come la chimica e il rituale condiviso insieme creino uno spazio liminale aperto a nuove possibilità; e come all’interno di quello spazio, il gruppo diventi una specie di organismo vivente che respira, qualcosa di più grande della somma degli individui presenti» (p.261).
Esplorando tre sostanze psicoattive apparentemente molto diverse tra loro (per storia ed effetti sulla mente umana) Pollan arriva a farci riflettere su quanto sia stretto il legame che ancora persiste tra la nostra mente e il mondo naturale. Ci riteniamo degli esseri complessi ed evoluti, ma spesso non siamo consapevoli del fatto che le emozioni che proviamo e i comportamenti che adottiamo sono in gran parte il risultato di una serie di molecole chimiche accumulate nel nostro cervello. La cosa più sbalorditiva è infatti rendersi conto proprio del fatto che un qualcosa che esiste nel mondo esterno (un semplice fiore o un cactus) si sintonizzi a tal punto con le sostanze che sono già presenti dentro di noi da avere degli effetti reali sul nostro umore e sui nostri comportamenti. Piante che cambiano la mente ha quindi il pregio di farci riflettere su questo aspetto – e sui suoi risvolti inquietanti e rassicuranti al tempo stesso – ridimensionando la centralità dell’essere umano all’interno del mondo naturale e ricordandoci che siamo pur sempre animali.
Francesca Rossi
Foto in evidenza di Scott Webb da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/arte-graffiti-modello-trama-7079093/
[1] All’interno del libro, Pollan riporta una dichiarazione non confermata che Ehrilichman – il consigliere per la politica interna di Nixon – avrebbe rilasciato a Dan Baum.
