Lasagna è una rubrica aperiodica, curata da Mattia Grigolo.
Racconta libri fuori dalle righe. Alle autrici e agli autori viene
chiesto di rispondere a delle parole come se fossero delle
domande, per libere associazioni. Il perché la rubrica si chiami
Lasagna non è importante, è una parola come un’altra. Una
libera associazione, per l’appunto.
Qualche settimana fa, io ed Emanuela Cocco stiamo parlando della scrittura, della produzione di libri. Lei dice che è tornata a scrivere dopo un periodo di risacca creativa. Dice che sta provando a essere meno “schizzata” nella scrittura. Credo di capire cosa intenda. Lo capisco perché ho letto il suo esordio, Tu che eri ogni ragazza (Wojtek Edizioni), un libro a tratti estremo nella scrittura e nella strutturazione. Ho letto anche Trofeo (Zona 42), il suo secondo lavoro che, per gli addetti ai lavori, è una novella, un libricino per tutti gli altri.
Trofeo è un racconto difficile, ma che riconosce una scrittura e una capacità di non-adattamento allo stilema che mi ha colpito molto. È il modo in cui Emanuela si approccia alla “sua” voce narrante che lascia interdetto il lettore, il quale si deve prima abituare all’oggetto che ha in mano e poi lo deve sopportare. Succede perché Emanuela sa scrivere, il che sembra banale, sembra. È bene ricordarlo. È proprio grazie alla padronanza pressoché naturale con cui si approccia a ciò che sta raccontando che le riesce di essere difficile, anticonformista e originale.
Eh, a proposito di oggetti ho chiesto a Emanuela di raccontare il suo libro, di aprire i cassetti e mostrarci ciò che è sempre rimasto nascosto nel buio.
SONO UN TROFEO
Il trofeo non è mai uno solo. Sono tanti e sono intercambiabili perché con il tempo perdono
parte del loro potere. Il narratore di questa storia è un nuovo trofeo, è stato appena catturato, è una striscia di stoffa strappata via dalla gonna di una donna che ora non esiste più. Un trofeo serve a chi lo usa per arrivare a provare piacere, serve all’uomo che ha ucciso la donna perché toccandolo riesce a eccitarsi, la stoffa è un trofeo perché riporta in vita un corpo morto. Tutta la vita che era nel corpo passa attraverso la cosa, e questo macabro incantesimo fa sì che l’oggetto di colpo senta, che l’oggetto perda la sua pacifica assenza di consapevolezza, il suo statuto di cosa, e cominci a sentire. Questa cosa, quindi, si sveglia. È frastornata, si ritrova viva, catapultata nel bel mezzo di un gioco sessuale, necrofilo. Quest’uomo, che lei non conosce, che la donna morta ha incontrato, la sta usando per rivivere il fatto e masturbarsi, evocando il sangue e la violenza, la morte. Questa cosa ha il potere di farlo venire. La cosa è il premio, la cosa è quello che riporta indietro i corpi dalla morte. Questo vuol dire essere un Trofeo. E tutto ha inizio quando la cosa scopre il suo potere. Sente l’affermazione del gesto su di sé, pensa: deve essere questo quello che è chiamato vivere, questo momento più o meno lungo, ingestibile e senza senso, la vita. Allora partecipa al rituale, smette di essere fredda, e di colpo esiste. Deve essere questa perdita di ordine e di senso e di certezza, vivere, questa paura intensa, attimi di felicità raggiunta, questa sofferenza ingiustificabile, quest’attimo di protagonismo impensabile, la vita. La cosa accetta di partecipare, precipita nel gioco, la cosa che dà la voce a Trofeo è nata.
INVOLUCRO
Quello che conta è liberarsene, o questo oppure avremo una storia scritta guardandosi le spalle, che è niente, la storia scritta chiedendosi a ogni frase come verrà preso quello che abbiamo scritto. Restare dentro l’involucro in cui ci hanno confezionati oppure uscire, scrivere la storia che ci si aspetta da noi, oppure la nostra. Rompere l’involucro della storia e delle frasi e delle immagini che ci metti dentro è una scelta come un’altra, non dico che sia la migliore.
Per me è così o niente. È possibile che alcune di queste immagini nude, queste immagini in
attesa di noi lì fuori, ci facciano venire il voltastomaco. Da qualche parte nel mondo, ora mentre parliamo, qualcosa si muove contro il nostro prototipo accettabile di essere umano,
qualcosa infuria e infanga tutto, qualcosa opprime l’altro, lo violenta e lo tortura. Questa cosa esiste a prescindere da noi, non è detto che ci dovremo farei conti. L’involucro che ci protegge è anche quello che ci rende così prevedibili. C’è qualcosa che è possibile vedere, scrivere, pensare, solo se quell’involucro lo fai a pezzi. Sotto la patina delle cose, nell’ordine che dai alle frasi, nella scelta delle parole, c’è una presa di posizione: ignorare la cosa oppure prenderla in considerazione. Trofeo è una storia scritta da un fuori? Ci ho provato.
LUI
Lui è solo una serie di ipotesi, approssimazioni, congetture nate da letture e visioni intorno al
tema dell’omicida seriale. Opere che hanno provato a ritrarlo nel migliore dei modi, che poi è
il peggiore. È in questi posti che l’ho incontrato per la prima volta, è lì che continuo a tornare
per cercare di metterlo a fuoco. Alcuni di questi luoghi sono particolarmente interessanti e ci ho incontrato tipi spaventosi. Sono entrati a far parte del mio immaginario, non ne sono mai usciti. Facciamo un gioco: ne elenco qualcuno, i migliori, quindi i peggiori di tutti.
Lui è Mark Lewis (Peeping Tom, un film di Michael Powell.) È solo un bambino e il padre si diverte a usarlo come cavia per i suoi studi sulla paura. Esperimenti terrificanti che lasceranno il segno. Da adulto diventa un bel ragazzo con l’hobby del cinema sperimentale: ama riprendere le sue vittime mentre stanno morendo. Questo pazzo omicida è interpretato
da Karlheinz Böhm, lo stesso che poi interpreterà il crudele marito di Martha di Rainer Werner Fassbinder e per me già basta questo. La sua faccia da sadico, il suo vizio oscuro, la sua essenza spietata e fragile, la sua vulnerabilità mortifera.
Lui è Anton Phibes (The Abominable Dr. Phibes, un film di Robert Fuest.) È un medico, ma anche un organista, ed è un vedovo rimasto sfigurato e da tutti creduto morto in seguito a un terribile incidente stradale, avvenuto mentre cercava di raggiungere l’ospedale in cui era ricoverata, in fin di vita, la moglie. Phibes, con il volto sfigurato, indossa una maschera in lattice ed è seduto davanti al ritratto della moglie Vittoria Regina, una splendida donna dai capelli corvini, morta in sala operatoria. Con l’aiuto di un sintetizzatore vocale (il jack dell’apparecchio inserito direttamente nella gola) Phibes declama, solenne e meccanico, parole d’amore e ci dà notizia del semplice innesco che tiene in piedi la storia: una vendetta, nove omicidi. “Nove eternità per la tua.” Lui qui è Vincent Price, ed è spietato ma è Price e quindi è anche divertente, un sadico eccentrico e giocoso. Gioca con le vittime, si diverte un
mondo, e anche noi.
Lui è Dente di fata (Manhunter, un film di Michael Mann.) Morde le sue vittime, questo il motivo del suo soprannome. Lavora in un laboratorio fotografico e si innamora di Reba, una collega cieca. Mentre fanno l’amore guarda i filmati che ritraggono le sue vittime. Anche lui ha bisogno di vedere il lavoro della morte, anche lui vuole lo spettacolo della paura. Gli danno la caccia. Vuole essere visto, amato. Si specchia nello sguardo di chi ha ucciso. L’amore è una cosa impossibile, non saprebbe da dove cominciare. Tutto è già scritto. La scena in cui lui e Reba accarezzano una tigre addormentata è indimenticabile.
Lui è dentro Farfalle, un racconto di Ian McEwan. La vecchia storia, questo amore che si nasconde, questa voglia di tirare un calcio a un pallone e partecipare al gioco della vita. Questo gioco impossibile per lui.
Lui è Henry (Henry: Portrait of a Serial Killer, un film di John McNaughton.) Tutta quella morte nella sua testa. I corpi e il sangue e la violenza, nella sua testa. Tutto si svolge lì dentro, lì dentro si ammassano i corpi e la paura, più corpi nella sua testa che altrove, lì dentro ogni cosa urla e gronda sangue. Quello che è accaduto e quello che è stato solo immaginato coincidono, lui è fatto così.
Lui è tutti gli assassini di cui ha scritto Derek Raymond. È il maniaco che ha straziato il corpo di Dora Suarez, lui è ogni assassino a cui il sergente della sezione Delitti irrisolti darà la caccia. Brutale, sciocco, privato per sempre della realtà, che lui attraversa come un incubo destinato a ripetersi finché durerà la sua vita e quella delle sue vittime. Cieco e crudele, come il caso, come la vita stessa.
CASSETTO
La drammaturgia dell’assedio mi ha sempre affascinato, ho provato a scrivere la mia. In I
sequestrati di Altona di Jean-Paul Sartre un uomo vive per oltre dieci anni rinchiuso nella sua
stanza. Tra quelle mura inscena un perenne tribunale immaginario. In un dramma di Ibsen, L’anitra selvatica, padre e figlio vanno a caccia in un solaio abitato da piccioni, conigli, e l’anatra del titolo. Sono due testi che amo e che mi hanno insegnato molto. Una particolare visione del mondo arriva quando si è in cattività, una visione sconfinata, libera, forse anche un po’ folle, dettata dalla prigionia che noi tutti viviamo. Il cassetto è lo spazio angusto in cui viviamo confinati. La scoperta spaventosa: non è detto che siano gli altri a ficcarci lì dentro, possiamo farci questo da soli. Ogni rifugio è anche una prigione. La cattività in cui vivono i trofei è spaventosa, eppure il cassetto è il solo posto in cui possono sentirsi al sicuro, perché fuori è riserva di caccia.
PERSONA
È duro diventare una persona, per la maggior parte della nostra vita siamo un ammasso di
fatti che ci sono accaduti, di idee approssimative su noi stessi, di compiti che ci assegniamo da soli. La storia della nostra vita, di come queste parti irrelate, di come queste parti smangiucchiate dalla contingenza, sono rimaste insieme negli anni, è un lavoro che non sempre ci viene bene. Ho pensato a cosa voglia dire liberarsi da questa esigenza dI dover giustificare a noi stessi di essere una persona, una sola identità, una vita che abbia un senso, una direzione, una finalità. Allora ho pensato alla pace delle cose, che non hanno bisogno di tutto questo. Ho pensato alla loro pace, al silenzio del loro momento su questa terra o altrove, al fatto che qui o altrove per loro è lo stesso, ho pensato alle cose e al fatto che ci sopravviveranno. Ho provato invidia. In questa storia provo a togliergli un po’ di questa pace, per poco, le faccio soffrire un po’. Ecco che una cosa di colpo diventa in parte una persona. Questa cosa non gli piace per niente, come darle torto? Si sente truffata, non capisce cosa c’è da guadagnarsi a sentire tutto, a sentirsi. Vuole tornare indietro. Va bene la felicità, va bene la vita e tutto il resto, ma essere una persona fa paura, non c’è modo di fuggire la sensazione che sia una cosa spaventosa, esistere.
MARIONETTA
Dici marionetta e io penso subito a Che fine ha fatto Baby Jane? (il film di Robert Aldrich con Bette Davis e Joan Crawford) che grande film! La prima scena parte con il pianto di una bambina. È spaventata da un pupazzo a molla, un fantoccio meccanico antropomorfo, una cosa nata per divertire, che però la spaventa. La voce fuori campo di un uomo dice alla bambina: Vuoi vederlo un’altra volta? Non avere paura. Ma la bambina piange sconsolata, poi, in controcampo, ci viene mostrato di nuovo il pupazzo, il fantoccio vestito da pagliaccio e un sorriso dipinto sul viso, e vediamo ora che anche lui sta piangendo. Questo brevissimo
prologo mi ha sempre fatto venire una grande tristezza, e poi ho sempre adorato quel film. Il punto è che Baby Jane è una bambina che presto diventa solo un fantoccio, che da subito è
usata, dalla famiglia, da chi dice di amarla, come una marionetta, e poi anche quando la sua
stupida recita non serve più a nulla, quando lei è diventata solo una mezza pazza attrice
sempre ubriaca, anche allora non può fare a meno di ripetere la stucchevole canzoncina e tutti gli stupidi gesti che le hanno insegnato. La marionetta è sinistra, è una bambola che non ce l’ha fatta a essere amabile. Vuole essere graziosa e invece è inquietante, proprio come Baby Jane quando fa l’inchino in uno dei suoi ultimi improponibili spettacolini domestici. Quel film è spaventoso ma è anche dolce e commovente ed era proprio questo quello che volevo raggiungere con Trofeo, volevo scrivere qualcosa che fosse insieme raccapricciante e tenero, qualcosa che, prima di salutarci, lasciasse nel lettore qualche lacrima buona.
CORPO
Mi piacerebbe saper scrivere i corpi come ha fatto Lawrence in L’amante di Lady Chatterley. In questa storia, però, i corpi si disfano sotto terra, nessuno di questi scorpi è stato davvero
toccato come accade in quel romanzo. Qui vale di più la frase di Kafka, con la quale sono d’accordo da sempre, che dice: la solida delimitazione dei corpi è spaventosa. Ecco perché i
trofei vogliono ricongiungersi alle loro persone, perché le cercano nei rimasugli di ossa e
carne che sono state, perché questi corpi si riaffacciano nel paesaggio così sezionati e feriti e urlanti fino a far impazzire chi li ha smembrati e divisi per sempre. Lui a un certo punto si
chiede: cosa devo farne di questo corpo? Se lo chiede e non è chiaro se questa domanda sia riferita al suo corpo o a quello delle vittime. Del resto lui non sa cosa voglia dire stringere un corpo vivo, perché nel momento stesso in cui lo tocca quel corpo è destinato a morire, quello della vittima e il suo stesso corpo, che forse non è mai stato sfiorato da un corpo vivo, non così come insegna Lawrence, come quando si ha un’occasione, la migliore, di toccare la vita e di provare a comprenderla.
SERIALITA’
Le serie mi piacciono perché non fanno finta che le cose possano davvero finire in un modo
certo. Prendi una serie colossale come The Shield, come finisce? Con la certezza che uno come Vic Mackey non accetterà nessun finale prestabilito, lo decide lui come finisce o non finisce la sua storia, e infatti corre in strada. Le serie danno modo a chi scrive di pensare ad architetture complesse, di giocare con archi di trasformazione (o involuzione) non troppo prevedibili. Mi piacerebbe un giorno avere la forza immaginativa e testuale per scrivere una serie meravigliosa come il ciclo della Factory di Derek Raymond. In una ideale serie della morte e della paura Trofeo è uno spinoff del romanzo più lungo che sto scrivendo per Wojtek.
FANTASMI
I miei fantasmi li tengo a bada creandone altri completamente inventati. Sono del tutto incapace di scrivere cose autobiografiche, non mi interessa farlo. Per me il bello è proprio creare il mostro assemblando pezzi nuovi. So già quello che è stata la mia vita, non voglio pubblicare il mio diario romanzato. Il fantasma che ho in mente non somiglia a qualcuno che ho conosciuto, a qualcosa che ho vissuto perché la somiglianza esteriore, di fatti, circostanze, luoghi, volti, battute di dialogo, non assicura l’autentica resa di quello che ho scoperto vivendo quello che ho vissuto. Per capirlo devo inventare una storia, per incontrare davvero i miei fantasmi devo rinunciare a ritrarli così come li ricordo, devo rifargli un viso nuovo. Entrano in scena e parlano una voce che non riconosco. Per capire quello che hanno da dirmi devo attraversare una storia che può stupirmi o farmi sentire disorientata. La storia che non ho mai vissuto è quella che mi rappresenta di più al momento, mentre la sto scrivendo.
FINIRE
Non c’è dubbio che accadrà. Il problema, riguarda tutti noi, è in questa consapevolezza. Nella vita le cose finiscono senza quel senso in più che mettiamo nelle storie, anche quelle (le migliori) nelle quali non ci sono lezioni da dare o valori da trasmettere. Le storie non devono significare qualcosa, o servire a qualcosa, o farmi capire qualcosa di preciso, non è questo quello che mi aspetto quando leggo. Ma voglio vivere un’esperienza intensa, voglio attraversare il testo in prima persona, non voglio restare inchiodata a una sedia ad ascoltare
le parole in libertà dell’autore. Un’esperienza intensa è quello che vorrei lasciare al lettore quando la mia storia sarà finita. Un senso di pienezza in questo finire fittizio che non esisterà mai in quella fine concreta e definitiva che ci aspetta.
SCRIVERE DI NOTTE
Non è tanto una questione di orario ma di intensità. Scrivere di notte è un modo di stare nel testo, e nella vita. Mi ci devo calare dentro, voglio andare in profondità. La notte di ognuno è unica. Nessuno vive la stessa notte, neanche quelli che vanno a dormire presto, tutti alla stessa ora. La notte è il momento in cui ci si incontra con quello che davvero conta per noi, e si è soli, è il momento in cui veniamo raggiunti da quello che siamo senza tutte le interferenze che accompagnano la nostra giornata. Scrivere di notte, quindi è un proposito, una promessa: non permetterò a niente e a nessuno di interferire con la mia scrittura. Suona un po’ solenne, ma più o meno è questo, non che a qualcuno importi tanto da volersi intromettere, capiamoci. Nessuno di noi è così importante. Ma per interferenze intendo più o meno tutte le stronzate che si mettono in mezzo tra noi e le frasi. Scrivere di notte vuol dire che al momento opportuno avremo la determinatezza di allontanarle per restare soli con le parole, in uno spazio solo nostro, lì, dentro la frase, nonostante la stanchezza o la delusione, o, l’euforia per qualcosa di nuovo, a qualsiasi costo.
QUAL È LA PAROLA?
Beckett lo ha detto e lo dirà fino alla fine con questa sua ultima poesia. Siamo condannati a
non avere le parole per dirlo, possiamo dirlo attraverso le parole senza arrivare mai ad essere certi della nostra restituzione. Flaubert pronunciava l’insufficienza della vita, Beckett quella delle parole. La sua ultima poesia non può essere altro che una domanda. La stessa domanda chiude anche Trofeo. Le parole umane stanno abbandonando la cosa, lei sente questa separazione ma già non sa più dirla, le parole le sfuggono. Ora che avrebbe bisogno di possederle per dare un senso finale alla sua esperienza, ora quello che sente è questa separazione, questa cosa destinata a restare senza nome, ma non importa, la vita è proprio in questa tensione, in questo movimento che intensifica le domande proprio mentre il silenzio si fa sempre più denso e impenetrabile. Cosa resterà di noi quando le parole se ne saranno andate? Cos’è la nostra vita se non questo tentativo di trovare il modo, ogni modo è ammesso, per dire la vita? Dire l’ultima parola è impossibile, dobbiamo accontentarci di finire mentre la stiamo cercando.

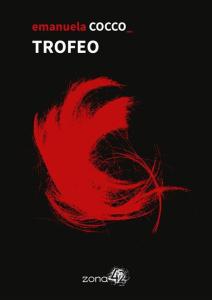
Grazie!
"Mi piace""Mi piace"