Viandanti, Edgardo Scott
(Italo Svevo Edizioni, 2023 -Trad. Alessandro Gianetti)
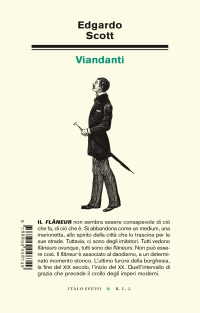
‹‹Leggere è vagare, c’è nella lettura un’attesa che non cerca risultati; chi è fragile o vuol sapere a ogni costo dove sta andando, non deve leggere.››[1], scrive Pascal Quignard. La lettura non implica il raggiungimento di un obiettivo ben definito, ma l’addentrarsi in territori sconosciuti nel quale nessuno si è mai inoltrato. Lo scrittore argentino Edgardo Scott si rende conto improvvisamente che la letteratura è un modo di muoversi e che tutto ciò che ama leggere ruota attorno a una sola parola: camminare. Con Viandanti (pubblicato da Italo Svevo) attraversa la letteratura che predilige analizzando passi su questo tema da Borges, Walser, Sebald, Thoreau e molti altri, in un percorso più o meno asistematico diviso per capitoli, ognuno per una tipologia di figura itinerante, ovvero flâneurs, passeggiatori, walkmans, vagabondi, pellegrini: tutte variazioni sul tema del movimento, ognuna con una propria peculiare traiettoria.
La passeggiata non esiste da sempre, ma è un prodotto storico: ha circa tre secoli di vita, da quando il filosofo tedesco Karl Gottlob Schelle pubblicò un trattato su di essa come modo per coltivare sé stessi. La passeggiata nasce assieme all’idea di progresso: il movimento sinuoso e inconcludente del passeggiatore si contrappone a quello meccanico e produttivo degli automi. In un certo senso, il passeggiatore è un prodotto industriale, una manifestazione del disagio della civiltà. Esso reagisce alla società di massa: è fuori dal movimento produttivo e rifiuta il mondo quasi fosse un asceta sui generis, così come i più recenti walkmans – chiamati così dal nome degli ormai obsoleti riproduttori portatili di audiocassette – camminavano ascoltando musica per reagire all’inquinamento acustico. La passeggiata è dunque una maniera di abbandonarsi, una fuga dal mondo:
‹‹Il passeggiatore è l’uomo che abbandona la causa, la sua causa – per un po’ di tempo, per sempre -, rinuncia all’attrito e allo spasmo per dimenticare sé stesso, per perdersi nel mondo. Per entrare o tornare nell’esistenza.››[2]
La passeggiata è una forma di conoscenza in quanto dimostra l’equazione sempre troppo trascurata tra pensiero e moto: pensare significa infatti essere in movimento. Il viandante è rappresentazione di come il pensiero non sia un prodotto, ma un processo il cui senso è nel suo farsi. Scott spiega come attraverso un autore a lui caro come Thoreau abbia compreso che non sono il cervello o il cuore gli organi deputati alla conoscenza, ma i piedi. Il camminatore non si muove per recarsi in un luogo particolare, ma per cercare di capire. Egli è fondamentalmente scettico sul mondo, per lui un posto vale l’altro poiché il suo palcoscenico è interiore: muovendosi, conosce sé stesso cercando il ritmo dei propri passi e in questo modo si installa nel mondo. Il movimento rappresenta una paradossale forma di stabilità, la sua maniera di abitare un mondo in cui è possibile sentirsi a casa ovunque e da nessuna parte.
Com’è possibile questo incontro tra stasi e movimento? Grazie alla leggerezza: il viandante vaga per le strade, ma non marcia né corre, i suoi piedi si librano sulla superficie terrestre in un modo che ricorda il verso del poeta romantico Wordsworth: ‹‹I was wondering lonely as a cloud›› (‹‹Vagavo solitario come una nuvola››). Questa assenza di gravità si percepisce nel passo citato da Scott dello scrittore argentino Sarmiento, che così descriveva i suoi vagabondaggi parigini: ‹‹Je flâne, io cammino come uno spirito, come un elemento, come un corpo senz’anima in questa solitudine di Parigi.››[3].
La leggerezza è una delle chiavi che permettono di comprendere il rapporto tra il viandante e il mondo: esso intrattiene con ciò che lo circonda una relazione sensuale ed erotica (dal momento che non c’è erotismo senza una certa dose di leggerezza). Sia in Borges che in Mansilla – altro grande scrittore argentino – emerge come l’atto del camminare sia legato ad una certa sensualità e quindi al desiderio. Esso comporta una tensione verso qualcosa di sconosciuto che riguarda anche la scrittura, azione che non differisce dalla lettura in questo senso: a detta di Scott per Mansilla ‹‹(…) camminare è desiderare, e desiderare è sempre scrivere.››[4].
Nel mondo odierno della velocità non è però possibile posarsi sul mondo con la leggerezza del viandante: nelle grandi città i ritmi ricorrenti di camminata sono la corsa frenetica o la marcia, avanzare spavaldo verso una meta. Il viandante e tutte le sue manifestazioni sono figure inattuali, che hanno concluso la loro parabola storica. Chi cammina per il gusto di camminare è una creatura rara, escludendo il trekking, che però implica l’avventurarsi nella natura come reazione a quel caos urbano nel quale il flâneur si immergeva. Nelle grandi città colui che cammina lentamente, fuori sincrono rispetto alla fuga generale della massa produttiva, è un outsider, una creatura di confine che serba in sé qualcosa di estremamente inquietante. Per questo Scott ritiene che nell’epoca dei Gps il vagare abbia una pulsione poetica, rappresenta una rivolta alla prosa della vita quotidiana.
Nella contemporaneità non si cammina più: ci si sposta semplicemente da un punto ad un altro, senza fare esperienza della traiettoria del movimento. I luoghi non esistono, sono solo momentanei punti di passaggio per raggiungere un obiettivo. Non camminare significa però anche non guardare. Viandanti si chiude con una postilla parigina: Scott osserva la massa che percorre gli Champs-Élysées presa dalla frenesia di rappresentare con i selfie la camminata sul famoso viale, ma senza farne esperienza. È così che la simulazione dell’azione – la sua rappresentazione – fagocita l’azione stessa del camminare, quindi del pensare.
Giacomo De Rinaldis
[1] citato a p. 96
[2] p. 36.
[3] citato a p. 22.
[4] p. 45.
Immagine in evidenza di Cottonbro studio da Pexels
